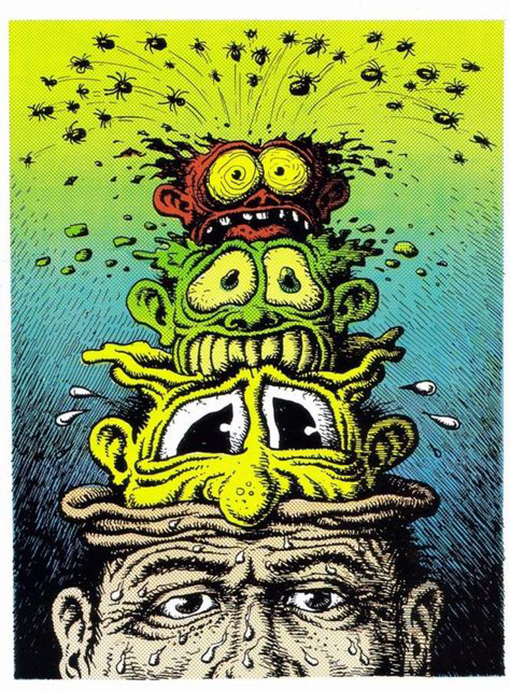
Catastrofe in corso
Annie Le Brun
Perché pubblicare liberamente qui un manifesto già pubblicato nel settembre 1995 negli Stati Uniti sul New York Times ed il Washington Post, ma sotto minaccia? E sotto la minaccia omicida di colui che, per diciott’anni, ha sfidato l’ordine americano coi suoi pacchi-trappola inviati ad alcuni rappresentanti della civiltà tecnica: universitari, ingegneri, informatici…
Perché editare un testo che gli specialisti di ogni genere, psichiatri, psicologi, sociologi, filosofi…, consultati dall’FBI e subito seguiti da commentatori autorizzati, professori e giornalisti, hanno rifiutato in blocco di comune accordo, sostenendo di trovarvi solo banalità contro la società industriale? Giudizio del resto ben presto rimbalzato sulla stampa francese, appena dopo l’arresto lo scorso 3 aprile di colui che è ritenuto l’autore di questo manifesto: «Confusa requisitoria contro l’alienazione della società industriale», secondo Libération del 9 aprile, oppure «Prosa che trasuda luoghi comuni sessantottini e affrancata al delirio neo-hippy della crescita zero e del rifiuto del Big Brother informatico», a detta de L’Express del 11 aprile.
Un tale consenso non può mancare di mettere in allarme alcuni, come me, soprattutto quando il nostro mondo ardentemente difeso da tanti esperti arriva ad offrirci, in meno di quindici giorni, tutto ciò che può confortare le tesi di un testo così screditato: la crisi della «mucca pazza», simbolo del disprezzo degli equilibri naturali; le smancerie dieci anni dopo la catastrofe di Chernobyl verso coloro che l’hanno provocata o ben poco combattuta, a riprova della collusione del potere coi fisici; infine l’oblio del massacro di piazza T’ien an Men pur di vendere la nostra tecnologia, come segno della più grave degradazione dei rapporti umani.
Per di più, quando nessuno degli esperti è in grado di rimarcare come, con questo andazzo, la nozione di criminalità diventi sempre più sfumata, perché non prestare attenzione alle idee di chi vuole farla finita con questa situazione, di colui che pare abbia al suo attivo, oltre al ferimento di ventitré vittime dei suoi pacchi, la morte nel 1985 di un commerciante di computer, nel 1994 del dirigente di un’agenzia di pubblicità associata alla compagnia petrolifera Exxon Valdez responsabile della marea nera del 1989 in Alaska, infine il dilaniamento del presidente dell’Associazione forestale della California?
Senza contare che l’unanimità suscitata da Unabomber (parola forgiata dall’FBI partendo dai suoi primi obiettivi, universitari e dirigenti di compagnie aeree) ha qualcosa di inedito. In effetti essa riunisce tutto ciò che si riteneva in opposizione: poliziotti e contestatori, uomini d’affari e uomini di pensiero, infine Stato e individui, questi unendosi quello come un sol’uomo nel medesimo rifiuto del «Genio perverso» («Twisted genius» intitolava US News del 15 aprile). Perché Unabomber è più del nemico pubblico numero uno di cui ci parlano. È il Nemico.
Fatto sta che, contrariamente ai criminali di diritto comune, tutti più o meno colpiti dal destino, lui ha scelto di rifiutare questo mondo. In questo senso «incarna la maggiore negatività in una società che rifiuta ogni negatività», come osserva Jean-Marie Apostolidès, a cui devo l’immediata conoscenza di questa vicenda. D’altronde, a parte questo amico, di cui conosco da tempo la libertà e l’acutezza dello sguardo, finora non c’è stato un solo universitario americano ad aver seriamente considerato le tesi di Unabomber. Se alcuni rarissimi intellettuali hanno ammesso l’interesse dell’una o dell’altra delle sue idee, è per insistere subito dopo sull’aberrazione dell’insieme. Il che non è comunque il caso di una parte del movimento anarchico, con diverse discussioni attorno a questo manifesto. Prova che Unabomber non si è forse sbagliato indicando gli universitari come i più sottomessi servitori di un sistema con cui aveva rotto definitivamente ogni legame. Ed è questo il suo crimine maggiore.
Si potrebbe supporre che, a partire dall’arresto di Theodore Kaczynski, in origine brillante matematico, il senso dell’intima collaborazione della polizia e della stampa per affibbiargli l’immagine di un «serial killer» a malapena diverso da tutti gli altri sia evidente: tutt’al più gli si concede d’essere l’assassino seriale più laureato, pur di non riconoscergli di avere idee. In particolare idee che l’hanno logicamente portato non a contestare questo mondo, ma a rifiutarlo totalmente, sia nella sua organizzazione che nella finalità.
Da qui l’interesse di questo testo, per quanto criminale sia l’autore. Costruito magari a casaccio nella teoria, nondimeno contiene impressionanti vedute su quanto accettiamo di vivere. Vedute la cui stranezza è legata all’estrema asocialità con cui si pone il suo autore, da almeno diciott’anni. Ma vedute che, per essere deformate e deformanti, ci mostrano ciò che già sappiamo senza ammetterlo, ad esempio che «è impossibile riformare il complesso industriale-tecnologico», per la ragione che «nella società industriale la restrizione della libertà è inevitabile».
E qui sta la novità del fenomeno, anche se si è tentati di collegarlo alla tradizione nichilista del tutto o niente. Ma dato che Unabomber viene dopo la rivoluzione di Ottobre, lo stalinismo, la caduta del muro di Berlino, dopo anche le contestazioni degli anni sessanta, la festa hippy, le iniziative ecologiste e i movimenti alternativi, la prospettiva è totalmente diversa. È per l’appunto anche contro questa storia che si colloca il Freedom Club, entità con la quale vuole confondersi l’autore di questo manifesto (per l’appunto firmato con le iniziali «FC») e che, a suo dire, sarebbe «strettamente anticomunista, antisocialista, antisinistra» ma soprattutto antiscienza e antitecnologia, su un fondo di anarchismo naturale.
Del resto, Unabomber è rivoluzionariamente scorretto. Questo costituisce per noi il suo vero interesse.
Prima di tutto difensore accanito dell’individuo, non prova imbarazzo per ciò che non ha sperimentato in prima persona. Ciò che sente lo dice, senza preoccuparsi dell’apparente maggiore o minore obiettività conseguente. Lo stesso accade con la sinistra universitaria americana. Si è parlato di regolamento di conti col suo vecchio ambiente, allorché Unabomber sviluppa le ragioni che ha di considerarlo il vivaio dei migliori promotori della società industriale, potendo riassumere l’attività della sua quasi totalità nel pensare questo mondo per costruirlo, cioè per perpetuarlo in maniera conforme al sistema. Il che è ciò che la pericolosa pagliacciata della demagogia «politicamente corretta» ha lo scopo di nascondere. E su questo punto il giudizio di Unabomber è senza appello: «I progetti della sinistra contemporanea non sono in conflitto con la morale dominante», benché lo provi molto dopo, mostrando che «l’ideale della sinistra è incompatibile con l’eliminazione della tecnologia moderna».
Certamente, per non considerare quanto egli sostiene sarebbe facile opporgli una debolezza nell’argomentazione, proprio quando la evoca alla fine del suo testo: «In mancanza di sufficienti informazioni e spinti dalla necessità di essere brevi, ci è stato impossibile formulare le nostre ipotesi in maniera più precisa e aggiungervi le riserve che si imporrebbero. Senza dimenticare che, in questo genere di analisi, il giudizio intuitivo ha la sua parte, e può condurre talvolta ad errori». Ma è per «necessità di essere brevi» che giunge a rivendicare il «giudizio intuitivo» o non è piuttosto per sfuggire a un pensiero «rivoluzionario» di cui per tutto il testo respinge implicitamente l’astrazione e il dogmatismo così poco in rapporto con la realtà?
In reatà, se non ha tempo da perdere, è per far passare tutte le impressioni di cui è sicuro, anche a costo di metterle insieme con le considerazioni teoriche che gli vengono in mente. Così, nello stesso modo in cui ha messo insieme le sue bombe integrando meno elementi possibile della società industriale, egli mette insieme il suo proposito ignorando deliberatamente la retorica rivoluzionaria. Si potrebbe pure definire il suo pensiero a-politico come il suo comportamento è a-sociale. Tutto ciò che gli uni e gli altri si sono sforzati di sacrificare alla logica della radicalità non gli importa. Egli presenta le sue idee come atti, essendosi servito in precedenza degli atti come idee.
Senza alcuna pretesa, contrariamente a quanto si è detto – «Unabomber tradito dal suo orgoglio», titolava Le Point del 13 aprile – questa opinione grossolana ha il pregio di rivelare, per contro, una sorta di buone maniere teoriche che ha forse colpito la riflessione rivoluzionaria, troppo spesso più preoccupata della propria coerenza che della realtà. Il che è significativo, allorché si assiste alla forsennata estetizzazione di teorie supposte radicali ma tuttavia non preparate in un simile processo. Pericolo che non tange Unabomber, il quale ha spinto il cattivo gusto, cioè l’onestà, fino ad annunciare i pericoli di quanto egli propone. Di tutti i trasformatori del mondo, credo sia l’unico a darci il terribile aut aut: catastrofe per catastrofe, quella che sceglieremmo non è forse migliore di quella che ci viene preparata?
E non è inoltre l’eco di un altro grido nella notte che, per non essere stato a suo tempo ascoltato, ritorna qui tragicamente deformato? Appena ho appreso di questo testo, ho subito ripensato alla rivolta di André Breton che, di fronte all’ampiezza del pericolo nucleare, poco tempo dopo Hiroshima esclamava: «Questa fine del mondo non è la nostra». Per dedurre immediatamente: «La trasformazione del mondo, di certo più necessaria e incomparabilmente più urgente che mai […] in ragione della comune minaccia che pesa su tutti gli uomini, richiederebbe d’essere ripensata da cima a fondo» (A. Breton, La Lampe dans l’Horloge, 1948).
Era il 1948 e nessuno vi diede seguito, le teste di sinistra meno delle altre. Quattro anni più tardi, Breton sarebbe tornato nei suoi Entretiens sulla questione atomica e sui cambiamenti che essa esigeva: «Contro ogni pigra abitudine, […] bisognerà iniziare a far traballare i vecchi quadri per procedere a un rifacimento generale delle idee oggi preconcette, di cui non ce n’è una che non sia opinabile». Il 18 febbraio 1958, davanti all’aggravarsi della situazione, firmava coi suoi amici surrealisti il volantino Smascherate i fisici, vuotate i laboratori. Nessun proposito avrebbe potuto essere più chiaro e meno ascoltato: «Nulla, assolutamente nulla, oggi distingue la Scienza da una minaccia di morte permanente e generalizzata. La questione si pone entro i seguenti termini: si tratta di sapere se la scienza saprà assicurare il benessere dell’uomo o condurlo alla sventura, poiché è ormai evidente che ha cessato d’essere un mezzo per diventare un fine. La fisica moderna ci ha promesso, ci ha dato, e ci promette ancora, come suoi tangibili risultati, cataste di cadaveri». Come immediata implicazione, per i firmatari di queste righe, che «il pensiero rivoluzionario vede le sue attività ridotte ai minimi termini, per ritemprarsi deve risalire alle sorgenti della rivolta e, oltre un mondo capace solo di nutrire il proprio cancro, ritrovare gli impulsi preconsci del furore».
Questo furore ha incontestabilmente accompagnato tutto il percorso di Unabomber. Sfortunatamente, essendo stato deliberatamente ignorato da coloro che nel corso degli ultimi cinquant’anni si sono di volta in volta proposti di cambiare il mondo, eccolo riapparire qui, prigioniero di una solitudine assoluta, per non aver mai potuto generare quell’altra maniera di pensare auspicata da Breton.
Da una decina di anni circa gli uni e gli altri non hanno mancato di criticare questo o quell’effetto della tecnologia. Gli ecologisti sono diventati specialisti, consultati dagli uomini di potere come altri specialisti, costretti oramai – da una situazione tanto allarmante – a mostrare di preoccuparsi dei misfatti della tecnica. Ma chi si è proposto di ripensare tutto sotto questa luce di catastrofe? Chi ha fatto affidamento, come Breton cinquant’anni fa, su quel sentimento di rivolta, in fin dei conti ogni volta ostacolato dai limiti di una teoria che si pretende rivoluzionaria?
Per essere anzitutto d’ordine sensibile, questa rivolta è un’arma che non uccide, finché siamo capaci di farne uso. Ma lo siamo ancora? Questo è uno dei gravi interrogativi che ci pone Unabomber. Soprattutto quando, di fronte ai recenti danni dell’ingegneria alimentare, nessuno – perlomeno in Francia – ha saputo riconoscere che si trattava già dello stesso avvenire della stessa società industriale, giustamente dipinta da colui che è assai più comodo rappresentare come un «pazzo bombarolo» («mad bomber»).
Attenzione, questa cecità è una pericolosa bomba a orologeria.
[Prefazione al Manifesto di Unabomber: il futuro della società industriale,
a cura di Jean-Jacques Pauvert, 1996]




