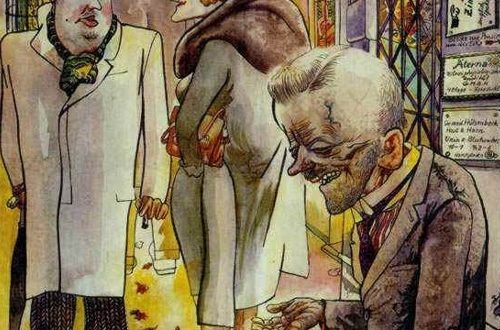Gaza, dove nessun essere umano può esistere
Saree Makdisi
Un mio amico australiano-palestinese è stato recentemente invitato dalla televisione nazionale australiana per discutere della situazione a Gaza e dintorni. Gli intervistatori bianchi hanno posto le solite domande: Può giustificare ciò che abbiamo visto compiere dai militanti di Hamas? Una simile violenza come ha aiutato la causa palestinese? Com’è possibile difendere il massacro di giovani appassionati di musica in un raduno musicale? Difende Hamas? Probabilmente si aspettavano una reazione di difesa da parte sua, ma lui con calma, nel suo morbido inglese dall’accento australiano, ha subito ribaltato l’intervista: «Vorrei sapere per quale motivo sono qui oggi, e perché non sono stato invitato l’anno scorso», ha detto garbatamente. Alla vigilia del 7 ottobre, ha sottolineato, le forze israeliane avevano già ucciso più di duecento palestinesi dall’inizio del 2023. L’assedio di Gaza risale a più di sedici anni fa ed Israele opera al di fuori del diritto internazionale da settantacinque anni. «Normale» in Palestina era un omicidio al giorno — ma un omicidio al giorno in un’occupazione decennale non è davvero una novità; di certo non giustifica un’intervista in diretta su un canale televisivo nazionale. Ai palestinesi è stata data adesso l’opportunità di parlare perché i media occidentali all’improvviso si preoccupano, e si preoccupano («come dovremmo preoccuparci», ha aggiunto il mio amico) perché questa volta le vittime sono civili israeliani. Nei giorni successivi al 7 ottobre, l’Australia ha mostrato un forte sostegno ad Israele: il Parlamento e l’Opera House di Sydney sono stati illuminati coi colori della bandiera israeliana; il primo ministro ha dichiarato che le manifestazioni filo-palestinesi dovrebbero essere annullate in segno di rispetto per i morti israeliani; il ministro degli Esteri è stato criticato per aver affermato che Israele dovrebbe sforzarsi di ridurre al minimo le morti di civili a Gaza. «Bene, che ne è delle nostre vite?» ha chiesto il mio amico. «Che ne dite di illuminare un edificio per noi? Quando il nostro governo illumina gli edifici di azzurro e bianco, come dovremmo sentirci noi? Non siamo australiani? Qualcuno si preoccupa forse per noi? Un ragazzo di 14 anni è stato bruciato vivo in Cisgiordania dai coloni israeliani. E noi?»
I conduttori sono colti di sorpresa. Non è questa la piega che avrebbe dovuto prendere l’intervista.
Quelli di noi, come il mio amico, che vengono invitati dai media occidentali a fornire una prospettiva palestinese sul disastro in corso a Gaza, sono ben consapevoli della condizione che ci permette di parlare: il tacito presupposto che la vita del nostro popolo non conti quanto la vita delle persone che contano. Le domande vengono inquadrate sull’attacco iniziale di Hamas contro i civili israeliani (l’attacco di Hamas contro obiettivi militari israeliani e contro la cintura israeliana di fortificazioni, torri di guardia e cancelli delle prigioni che circondano Gaza passa inosservato), e ogni tentativo di collocarlo in un quadro storico più ampio viene deviato e riportato all’attacco stesso: «Come potete giustificarlo? Perché cercate di spiegarlo invece di condannarlo? Perché non denunciate semplicemente l’attacco?» Se i commentatori palestinesi vogliono essere interpellati sulla violenza israeliana contro i civili palestinesi — sulla storia della pulizia etnica e dell’apartheid che hanno prodotto la contemporanea Striscia di Gaza e la violenza a cui stiamo oggi assistendo; sulla violenza strutturale di decenni di occupazione israeliana che taglia fuori gli agricoltori dai loro campi, gli insegnanti dalle loro classi, i medici dai loro pazienti e i figli dai loro genitori — dobbiamo chiedere di essere interpellati. Ed anche così, le domande non arrivano.
Nelle ultime due settimane ho parlato con molti giornalisti di diversi organi di stampa. Tranne rare eccezioni, lo schema è lo stesso, come lo è da anni. Una recente apparizione su un importante canale di notizie americano via cavo è stata cancellata all’ultimo minuto, subito dopo aver inviato i punti di discussione che il produttore mi aveva chiesto di presentare; non erano ovviamente i punti di discussione che avevano in mente loro. Per anni sono stato nella lista degli ospiti regolari della BBC per interviste radiofoniche e televisive sulla Palestina — finché, nel corso di un precedente bombardamento israeliano di Gaza, ho fatto presente all’intervistatore che stava facendo le domande sbagliate e che le domande importanti riguardavano la storia e il contesto, non solo quello che stava accadendo in quel momento. Quella è stata la mia ultima apparizione alla BBC.
Come può una persona rimediare a settant’anni di false dichiarazioni e distorsioni deliberate nel tempo di una breve frase? Come si fa a spiegare che l’occupazione israeliana non ha bisogno di ricorrere alle esplosioni — e nemmeno ai proiettili e alle mitragliatrici — per uccidere? Che l’occupazione e l’apartheid strutturano e saturano la vita quotidiana di ogni palestinese? Che i loro risultati sono letteralmente letali, anche quando non vengono sparati proiettili? I malati di cancro a Gaza vengono privati di cure salvavita. I neonati alle cui madri viene negato il passaggio dalle truppe israeliane nascono nel fango, sul ciglio della strada nei checkpoint militari israeliani. Tra il 2000 e il 2004, al culmine dei blocchi stradali e checkpoint del regime israeliano in Cisgiordania, sessantuno donne palestinesi hanno partorito in questo modo; il risultato è che trentasei di quei neonati morirono. Ciò non ha mai fatto notizia nel mondo occidentale. Queste non sono perdite da deplorare. Sono al massimo statistiche.
Quello che non ci viene concesso di dire, in quanto palestinesi che parlano ai media occidentali, è che tutte le vite hanno lo stesso valore. Che nessun evento si verifica dal nulla. Che la storia non è iniziata il 7 ottobre 2023, e se si inserisce ciò che sta accadendo nel più ampio contesto storico del colonialismo e della resistenza anticoloniale, l’aspetto più rilevante è che nessuno nel 2023 dovrebbe restare sorpreso dal fatto che condizioni assolute di violenza, dominio, oppressione e controllo producono a loro volta una violenza spaventosa.
Durante la rivoluzione haitiana all’inizio del XIX secolo, gli ex-schiavi massacrarono coloni bianchi, uomini, donne e bambini. Durante la rivolta di Nat Turner nel 1831, gli schiavi ribelli massacrarono uomini, donne e bambini bianchi. Durante la sollevazione indiana del 1857, i ribelli indiani massacrarono uomini, donne e bambini inglesi. Durante la rivolta dei Mau Mau negli anni 50, i ribelli keniani massacrarono coloni uomini, donne e bambini. Ad Orano, nel 1962, i rivoluzionari algerini massacrarono uomini, donne e bambini francesi. Perché bisognerebbe aspettarsi che i palestinesi — o chiunque altro — siano diversi? Evidenziare questi fatti non significa giustificarli, significa comprenderli. Ognuno di questi massacri è il risultato di decenni o secoli di violenza e oppressione coloniali, di una struttura di violenza che decenni fa Frantz Fanon spiegò ne I dannati della terra.
Ciò che non ci viene permesso di dire, in altre parole, è che se si vuole che la violenza finisca, è necessario porre fine alle condizioni che la producono. Bisogna porre fine all’odioso sistema di segregazione razziale, di espropriazione, di occupazione e di apartheid che ha sfigurato e tormenta la Palestina dal 1948, conseguenza del brutale progetto di trasformare una terra che è sempre stata la casa di molteplici culture, fedi e linguaggi in uno Stato con un’identità monolitica che esige l’emarginazione o l’espulsione definitiva di chiunque non si adegui. Ciò che sta accadendo oggi a Gaza, se è una conseguenza di decenni di violenza d’insediamento coloniale, e per essere compresa deve essere posta all’interno della storia più ampia di questa violenza, ci ha spinto ad un punto mai raggiunto nella storia del colonialismo.
In qualsiasi momento, senza preavviso, ad ogni ora del giorno e della notte, qualunque condominio nella densamente popolata Striscia di Gaza può essere colpito da una bomba o da un missile israeliano. Alcuni degli edifici colpiti crollano semplicemente come strati di frittelle di cemento, seppellendo morti e vivi sotto cumuli di macerie. Spesso i soccorritori che gridano «hadan sami’ana?» («qualcuno ci sente?») sentono le grida di aiuto dei sopravvissuti che provengono da sotto i detriti, ma senza mezzi pesanti per sollevarli tutto quello che possono fare è grattare invano sulle lastre di cemento con piedi di porco o a mani nude, nella vana speranza di riuscire ad aprire varchi sufficientemente ampi da consentire di tirare fuori i sopravvissuti o i feriti. Alcuni edifici vengono colpiti da bombe così pesanti che le palle di fuoco generate a volte scagliano parti di corpi o anche interi corpi carbonizzati — di solito quelli dei bambini, date le piccole dimensioni — fin nei quartieri circostanti. I proiettili al fosforo, approntati dagli artiglieri israeliani per esplodere con spolette di prossimità in modo che le particelle incendiarie piovano su un’area quanto più ampia possibile, danno fuoco a qualsiasi cosa sia infiammabile — mobili, vestiti, corpi. Il fosforo è piroforico: brucia finché c’è aria e fondamentalmente non può essere spento. Se aderisce a un corpo umano, deve essere asportato con un bisturi per non continuare a bruciare nella carne.
Uno dei corrispondenti arabi di Al-Jazeera testimoniava, parlando a proposito dell’onnipresente ronzio dei droni assassini di Israele: «Viviamo avvolti in un afrore di fumo e morte». Intere famiglie — venti, trenta persone alla volta — vengono cancellate. Amici e parenti che si cercano disperatamente spesso trovano solo rovine fumanti dove un tempo vivevano i propri cari, il cui destino è sconosciuto, scomparsi sotto il cemento oppure sparsi tra i resti di altre aree sempre più irriconoscibili. I sopravvissuti si ritrovano in una delle aree più affollate del pianeta, con telecomunicazioni fatiscenti, elettricità carente, sistemi sanitari al collasso, connessioni interrotte ed un futuro incerto.
Nel 2018, le Nazioni Unite avevano avvertito che Gaza — le cui infrastrutture di base (elettricità, acqua e sistemi fognari) sono state distrutte nel corso degli anni dalle incursioni e dai bombardamenti israeliani, lasciando il 95% della popolazione senza facile accesso all’acqua potabile — sarebbe diventata «invivibile» entro il 2020. Ora siamo nel 2023 e l’intero territorio, tagliato fuori dal mondo esterno, non può accedere a cibo, acqua, medicine, carburante ed elettricità, il tutto sotto incessanti bombardamenti da terra, mare e aria.
«Gli attacchi contro infrastrutture civili, in particolare l’energia elettrica, sono crimini di guerra», ha ammonito Ursula Von der Leyen, presidente della Commissione europea. «Con l’approssimarsi dell’inverno, privare uomini, donne e bambini di acqua, elettricità e riscaldamento», ha continuato, «sono atti di puro terrore». Von der Leyen ha ovviamente ragione, ma in questo caso si stava riferendo agli attacchi della Russia alle infrastrutture ucraine. Quanto agli attacchi di Israele alle infrastrutture di Gaza, Von der Leyen sostiene che Israele ha tutto il diritto di difendersi.
900, 1000, 1500, 1800, 2600, 3500, 4600, 5000, 5900, 6500. Le cifre dei morti, che nessuno riesce a seguire, aumentano ogni ora di venti qui e di trenta là, quando questo o quell’edificio crolla in un cataclisma di fuoco, fumo e macerie. Ogni giorno vengono uccise tre o quattrocento persone, come minimo. Ad un certo punto, fonti sanitarie a Gaza hanno riferito di 100 morti in una sola ora. Per ogni persona uccisa ci sono due, tre o più feriti, spesso gravi. Quasi la metà dei morti e dei feriti sono bambini piccoli; alcune delle immagini più dolorose degli attuali bombardamenti di Gaza, come di quelli precedenti, sono quelle di bambini morti, martoriati, coperti di cenere, fuliggine e polvere, avvolti nell’ultimo abbraccio da genitori uccisi nel tentativo di proteggerli. Finora, senza che si intraveda una fine, Israele ha ucciso quasi tremila bambini. I morti e i feriti, o spesso solo le parti di corpi recuperate — gambe, tronchi, teste maciullate — vengono portati in ospedali già traboccanti di feriti, a corto di forniture mediche e di carburante per i generatori d’emergenza. I letti degli ospedali sono tutti occupati da diverso tempo; i nuovi arrivati negli ospedali di Gaza sono ammassati nel loro stesso sangue nei corridoi o sui marciapiedi esterni; i medici riferiscono che sono costretti a dormire sui tavoli operatori dove sono costretti ad operare senza anestesia alla luce dei cellulari, usando aceto domestico per pulire le ferite perché non hanno altro a disposizione.
Con gli obitori straripanti e i cimiteri a corto di spazio, le autorità sanitarie di Gaza hanno iniziato a immagazzinare i cadaveri nei camion dei gelati, col sangue che si vede colare lentamente da sportelli decorati coi colori vivaci e infantili delle marche di gelato. Nei vicoli, nei cortili e nelle moschee improvvisate, quelli che ne sono capaci si raccolgono in lacrime e preghiere silenziose davanti a schiere di corpi, alcuni grandi e altri spesso pietosamente piccoli, avvolti in sudari intrisi di sangue in attesa della sepoltura. I parenti piangono su ogni fagotto, danno un ultimo bacio su una fronte dondolante mentre viene portata via per l’ultima volta, lasciando solo madri, padri, fratelli, sorelle, zii, zie e cugini in lacrime l’uno nelle braccia dell’altro — il loro turno in quei sudari non è tanto lontano. A volte non ci sono parenti; anche loro se ne sono già andati tutti. Il livello di morte e distruzione è così massiccio, così incessante, che spesso non c’è tempo per il lutto, e ogni giorno, ogni ora, gli israeliani inondano Gaza di morte. Un ospedale ha iniziato a seppellire i morti anonimi in fosse comuni, in mancanza del riconoscimento.
Nella prima settimana di bombardamenti senza sosta, gli israeliani hanno riferito di aver sganciato 6.000 bombe su Gaza, l’equivalente di un mese di bombardamenti al culmine delle guerre americane in Iraq e Afghanistan — paesi molto, molto più grandi della Striscia di Gaza (l’Iraq è oltre mille volte più grande della Striscia di Gaza). Hanno inoltre annunciato di aver sganciato più di mille tonnellate di esplosivi ad alto potenziale; alla fine della prima settimana, in altre parole, eravamo già nel novero dei kilotoni di armamenti nucleari, e la seconda e terza settimana sono alle porte. Solo nella prima settimana di bombardamenti, a Gaza sono stati distrutti 1.700 interi edifici. Moltissimi altri edifici sono stati danneggiati, spesso irreparabilmente. Ogni edificio comprende sette, otto, nove o più appartamenti, ciascuno dei quali era la vecchia casa di una famiglia adesso o di nuovo senza tetto oppure scomparsa. Come sempre, gli israeliani affermano di prendere di mira «infrastrutture del terrore». Come sempre, i corpi (o parti di corpi) estratti dalle macerie o raccolti nelle strade circostanti sono per lo più di donne e bambini, improbabili elementi della fantasmatica «infrastruttura del terrore» da cui il potere occupante — con la benedizione del suo superpotente padrone — dichiara di difendersi.
Dalle immagini strazianti che provengono da Gaza è evidente che gli israeliani, incapaci di individuare obiettivi militari chiari — nessun guerrigliero nella storia della lotta anticoloniale si è mai messo in mostra agitando le mani per diventare un evidente bersaglio — stanno colpendo indiscriminatamente obiettivi civili, distruggendo sistematicamente un edificio dopo l’altro, spesso spazzando via interi quartieri in un botto; l’ONU stima che i bombardamenti israeliani abbiano già danneggiato o distrutto il 40% di tutte le unità abitative di Gaza. Sui suoi siti e sui social-media, lo Stato israeliano si vanta con orgoglio del successo della sua campagna contro Hamas, ma le prove che fornisce di solito si limitano a fotografie di rovine urbane, e il risultato è l’accuratamente calcolata imposizione di non avere più una casa per un’intera popolazione.
Il 12 ottobre gli israeliani hanno intimato ad un milione di residenti nella parte settentrionale di Gaza di fuggire per salvarsi la vita. Ma non esiste nessun posto per loro dove andare e coloro che cercano di fuggire moltiplicano i rischi. La Striscia di Gaza si estende per 140 chilometri quadrati, è già una delle aree più densamente popolate del mondo. Se gli Stati Uniti avessero la stessa densità di popolazione di Gaza, conterebbero 60.000.000.000 di abitanti. Ovvero, sessanta miliardi. E ora gli israeliani stanno strombazzando che vogliono che la popolazione di questo minuscolo territorio si accalchi in qualche modo nella metà dell’area rimanente — e comunque stanno bombardando il sud di Gaza così come il nord e il centro. Nessun posto a Gaza è sicuro.
Già rifugiati una volta o a volte due (l’80% degli abitanti di Gaza sono rifugiati, sopravvissuti o discendenti di sopravvissuti alla pulizia etnica del resto del sud-ovest della Palestina nel 1948), i nuovi rifugiati si ritrovano ancora una volta a cercare rifugio, mentre gli israeliani avvertono oscuramente che molto, molto altro sta per accadere. Il 14 ottobre, una colonna di rifugiati terrorizzati che si spostava da nord a sud sulla via Salah al Din di Gaza City — specificatamente indicata sui volantini israeliani come corridoio sicuro — è stata bombardata, e settanta sopravvissuti ad altri bombardamenti sono stati uccisi e decine di altri feriti. I medici delle cliniche e degli ospedali nel nord della Striscia di Gaza si rifiutano di spostarsi insieme, dicendo che sarebbe impossibile soprattutto perché non c’è nessun posto dove trasferire i loro pazienti. Tutti gli altri ospedali sono pieni, ha detto il dottor Yousef Abu al-Rish dell’ospedale Shifa a nord di Gaza. «Inoltre», ha aggiunto, «la maggior parte dei casi sono instabili. E se vogliamo trasferirli, anche se ci fossero letti aggiuntivi in altri ospedali, cosa che non è, morirebbero perché troppo fragili per essere trasportati». I pazienti in terapia intensiva, i neonati nelle incubatrici, le persone attaccate ai ventilatori: morirebbero tutti se venissero trasferiti. Naturalmente rischiano di morire anche se restano sul posto, soprattutto quando finiranno le ultime gocce di gasolio e si spegneranno le luci. O se gli israeliani continueranno a bombardare ospedali e ambulanze come stanno facendo. Un terzo degli ospedali e delle cliniche di Gaza hanno già dovuto chiudere i battenti per mancanza di risorse.
«Lo spettro della morte incombe su Gaza», ha avvertito Martin Griffiths, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari. «Senza acqua, elettricità, cibo e medicine, migliaia di persone moriranno. Chiaro e semplice».
Pochi giorni fa gli israeliani hanno ribadito che sarebbe meglio, nel complesso, se l’intera popolazione del territorio — oltre due milioni di persone, la metà dei quali bambini — se ne andasse, o in Egitto o verso il Golfo. L’analista israeliano Giora Eiland ha detto con approvazione che l’obiettivo è quello «di creare le condizioni affinché la vita a Gaza diventi insostenibile». Di conseguenza, ha aggiunto, «Gaza diventerà un luogo dove nessun essere umano può esistere». Il Generale Maggiore Ghassan Alian dell’esercito israeliano, facendo eco al recente riferimento del ministro della Difesa ai palestinesi come «animali umani», ha dichiarato che «gli animali umani devono essere trattati come tali. Non ci sarà né elettricità né acqua [a Gaza], ci sarà solo distruzione. Volevate l’inferno, lo avrete».
Che tipo di persone parlano in questo modo, con un senso divino del loro potere su milioni di persone? Che mentalità producono simili proclami genocidi riguardo intere popolazioni?
Penso che ciò a cui stiamo assistendo non abbia precedenti nella storia della guerra coloniale. In sé la pulizia etnica disgraziatamente non è un’occasione così rara come si pretende; solo poche settimane fa, 130.000 armeni sono stati strappati dalle loro case nell’Artsakh dall’Azerbaigian (che, non a caso, è armato da Israele). Durante le guerre jugoslave degli anni 90, migliaia di persone della religione o dell’etnia «sbagliata» furono espulse dalle loro comunità in Bosnia, Serbia e Croazia. Quasi tutta — il 90% — della popolazione cristiana e musulmana della stessa Palestina è stata sottoposta a pulizia etnica da parte delle forze sioniste nel 1948. E possiamo risalire ai secoli XIX, XVIII e XVII, e ricordare la sordida storia di genocidi, stermini e schiavitù attraverso cui la civiltà occidentale ha fatto sentire la sua illuminata presenza in tutto il pianeta.
Ma, per quanto ne so, nessun caso di pulizia etnica è stato portato a termine attraverso l’uso massiccio di artiglieria e bombardamenti pesanti con sistemi d’armamenti ultramoderni, comprese bombe da una tonnellata (e munizioni anche più pesanti in grado di distruggere i bunker) da parte di israeliani che pilotano moderni aerei a reazione americani. Queste faccende solitamente vengono condotte di persona, con fucili o sulla punta di una baionetta. La pulizia etnica della Palestina nel 1948 venne portata avanti quasi interamente con piccole armi, ad esempio; i palestinesi massacrati a Deir Yassin, Tantura e in altri luoghi per spingere gli altri a fuggire in preda al panico sono stati colpiti con pistole, fucili o mitragliatrici a distanza ravvicinata, non colpiti da bombe da 500 chili sganciate da F35 che volano a più di 3000 metri di altezza.
In altre parole, ciò a cui stiamo assistendo è forse la prima fusione tra la violenza coloniale e genocida della vecchia scuola e le armi pesanti più all’avanguardia; un contorto amalgama del XVII secolo e del XXI secolo, confezionato ed avvolto in un linguaggio che richiama epoche primordiali e fragorose scene bibliche che ricordano l’annientamento di interi popoli: i Gebusei, gli Amalikiti, i Cananei e ovviamente i Filistei.
La cosa peggiore, se può esistere qualcosa di peggiore, è la quasi totale indifferenza mostrata da molti, dentro e fuori dalle nazioni del mondo occidentale. Di fronte allo shock e all’indignazione espressi da giornalisti, politici, governi per il massacro di civili israeliani da parte di palestinesi, il silenzio quasi generale sulla sorte dei civili palestinesi per mano di Israele è assordante: un silenzio sconvolgente, un silenzio straziante. Noi, che viviamo in paesi occidentali, non abbiamo né sostenuto né pagato un palestinese per uccidere civili israeliani, ma ogni bomba sganciata su Gaza da aerei forniti dagli Stati Uniti si aggiunge ad un conto che noi paghiamo. I nostri funzionari si stanno affrettando ad incoraggiare i bombardamenti e accelerare la consegna di nuovi armamenti.
Funzionari del Dipartimento di Stato hanno emesso circolari interne in cui invitano i portavoce a non usare frasi come «fine della violenza/spargimento di sangue», «ripristino della calma» o «allentamento dell’escalation/cessate il fuoco». L’amministrazione Biden in realtà vuole che i bombardamenti e il massacro continuino. Alla domanda sul piccolo gruppo di voci più o meno progressiste al Congresso che chiedono un cessate il fuoco e la fine delle ostilità, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha detto «pensiamo che si sbaglino. Pensiamo che siano disgustosi e pensiamo che siano vergognosi» Non ci sono «due campi qui», ha aggiunto la signora Jean-Pierre. «Non ci sono due campi».
I portavoce del governo sono calcolatori ed ipocriti; nichilisti all’ennesima potenza, non credono in realtà a nulla e soprattutto a ciò che loro stessi dicono. Ma lo stesso non si può dire delle persone intorno a noi che, disperatamente commosse dalle immagini e dalle storie della sofferenza israeliana, non hanno nulla da dire sulla sofferenza palestinese che avviene su scala molto più ampia. Come si può essere così insensibili? Non sto parlando degli sfacciati razzisti che chiedono esplicitamente la distruzione di Gaza e l’espulsione dei palestinesi. Mi riferisco alle persone comuni, molte delle quali — forse persino la maggior parte — sono decisi liberali in politica: sostenitori dell’uguaglianza di genere e razziale, in ansia per il cambiamento climatico, preoccupati per i poveri, insistenti nell’indossare mascherine per rispetto umano nei confronti degli altri, elettori del più progressista dei democratici. La loro indifferenza non è personale, è la manifestazione di una più ampia cultura di negazione. Queste persone sembrano non vedere o riconoscere la sofferenza palestinese perché letteralmente non la vedono e non la riconoscono. Sono troppo attenti, troppo concentrati sulla sofferenza delle persone con cui riescono a identificarsi più facilmente, persone che considerano simili a loro. Naturalmente, i mass media sanno come incoraggiare tali forme di identificazione, come costruire protagonisti e come portare gli spettatori a simpatizzare per un soggetto, immaginandosi al suo posto. Strozzando l’informazione, i media occidentali impediscono una eventuale identificazione con i palestinesi e riaffermano la percezione che esista una sola parte. Nel frattempo, sull’araba Al-Jazeera — i cui corrispondenti a Gaza e altrove in Palestina e Libano stanno fornendo un’appassionante e inflessibile copertura della catastrofe in corso a Gaza — la tragedia si sta svolgendo in tempo reale. Il 25 ottobre, il capo dell’ufficio di Gaza Wael Dahdouh era in onda quando ha appreso che sua moglie, suo figlio e sua figlia erano stati uccisi in un vicino attacco aereo israeliano. Il filmato lo mostra in ginocchio, che piange e mette una mano sul petto del figlio adolescente. «Si stanno prendendo la loro vendetta su di noi attraverso i bambini?» chiede Dahdouh. Per quelli di noi che stanno incollati ad Al-Jazeera in questi giorni, e per i quali Dahdouh è un volto familiare, questa perdita viene percepita come personale.
Alcune vite devono essere compiante e bisogna dare loro un nome e una storia, e le loro foto devono essere pubblicate sul New York Times o sul The Guardian insieme alle foto dei parenti in lutto. Altre vite sono solo numeri, statistiche di una macchina calcolatrice che sembra non smettere di aggiungere nuovi numeri, venti o trenta alla volta.